“La Milano che mi interessa è quella che soffre. A loro sono dedicate le mie canzoni di ambiente milanese. La nostra è una città troppo dura. Anche per chi ci sta bene, che è troppo duro a sua volta”.
Enzo Jannacci, il cantore dei disgraziati. Indubitabile che questo fosse il cuore della sua ispirazione: “La forza della mia canzone era il canto dei disperati. Si poteva anche cantare i ricchi, i nobili e loro disgrazie, ma allora mi interessava quello con le scarpe da tennis”. Eppure, sono almeno tre, se non quattro, i modi in cui si è concretizzata questa ispirazione. Quello amaro degli ultimi 30 anni.
E poi il patetismo mieloso di canzoni talvolta infelici, come Gli zingari, talvolta riuscite, come Vincenzina e la fabbrica, sulle quali la penso esattamente come Gianfranco Manfredi, suo amico e studioso, nonché cantautore anch’esso: in esse “affiora un che di 'posticcio' e un patetismo troppo sottolineato. La voce di Enzo diventa diversa, non più gli striduli falsetti da 'squilibrato', ma una voce "alla francese" che cerca toni teatrali ed effetti drammatici, studiati per far commuovere a tutti i costi. In questi testi si assume più volentieri la descrizione oggettiva, cioè non è il personaggio che si racconta in prima persona, ma è il cantante che racconta i personaggi dall’esterno […] In qualche modo queste canzoni funzionano meno. Non sono 'false' perché esprimono comunque un lato del carattere e della poetica di Enzo, ma sembrano 'di maniera' perché troppo 'di testa', troppo volute (anche se invece sono molto sentite e portano alla luce un disagio interiore espresso per segnali)”.
Cronologicamente, quest’attitudine oleografica e meno efficace, tipica di certo paternalismo da socialismo deamicisiano ottocentesco, si sviluppa, quasi come un senso di colpa, dopo due anni di collaborazione stretta con Dario Fo, il quale, conosciuto nel 1963 al Derby Club di Milano, aveva innestato nel repertorio di Jannacci un’ideologizzazione, anche se pur sempre di gusto surreale, a lui originariamente estranea.

(Enzo Jannacci e Dario Fo)
Come ha scritto sempre Manfredi, “Proprio nel momento in cui Enzo di fatto si stacca da Fo, sopravvive in lui come polo negativo un’inclinazione al 'foismo' che si manifesta in canzoni […] sulla guerra e la trincea, o in canzoni di allusione partigiana (l’Lp Sei minuti all’alba, 1965, ndr), o in un recupero di folk popolare, o addirittura in una riproposizione in chiave populista di temi religiosi”. Come fiumi carsici che si intrecciano e si separano, riemergendo periodicamente, patetismo oleografico, “foismo” e vena autentica, primigenia e originaria di Jannacci si ritrovano in tutta la produzione del musicista milanese. Già, ma qual è questa vena autentica?
Paradossalmente, Jannacci le diede un nome solo nel 1976, negli studi Fonorama di via Barletta a Milano, riascoltando la registrazione di Rido, alla presenza del solito Manfredi, allora anche suo collega nell’etichetta indipendente Ultima Spiaggia: “L’Enzo, con lo sguardo fisso, fa una "risata in piedi'. Trattasi di risata sua tipica […]. Dopo la risata, Enzo dice: 'È proprio un pezzo schizo'. Ripiomba in sala e lo fa ancora più schizo, ridendo così teso che si rimane in dubbio se ridere con lui o chiamare un’ambulanza per tutti. 'Schizo' sta per schizoide. Se Enzo ha rappresentato l’emarginazione l’ha fatto (e bene) in una forma assai particolare: l’esclusione dello schizofrenico, del discinetico, del nevrotico liberatosi nella follia e nel grido. Qui Enzo è grande […], perché lo schizo include il 'barbone' come un caso particolare […]. È lo schizo escluso che sta in ognuno di noi, noi 'quelli che', noi compressi dalle scarpe e da Milano, sempre lì per esplodere, noi che difficilmente si riesce a piangere e più facilmente si riesce a ridere di nervi. Una risata che non è neppure sberleffo, una risata imbarazzante, martellante, che per gridare la sua emarginazione non ha bisogno di lacrime, né di autocommiserarsi”. Insomma, è “l’Enzo surreale, l’Enzo del non-senso, del discorso libero, della follia e del dramma dello schizo” lo Jannacci vero e autentico.

Quando e dove nasce Enzo Schizo? Nella Milano anni '50, dell’incipiente, ma ancora di là da venire, miracolo italiano (che sarebbe stato il quinquennio 1958-1963): dopo il diploma (chi dice classico non si sa dove, chi dice scientifico al Leonardo Da Vinci, chi dice commerciale al Moreschi: peraltro, nessuna di queste scuole gli ha dedicato una riga in occasione della sua scomparsa), conseguito nel 1954 con l’amico Giorgio Gaberscik (avrebbe perso lo scik e sarebbe diventato solo Gaber) con cui organizzava spettacoli scolastici, entra nel giro dei locali milanesi d’allora (Taverna Mexico, Aretusa e Santa Tecla) e del nascente rock’n’roll italiano, prima da solo, poi come membro dei Rocky Mountains (il complesso che accompagnava Tony Dallara) e poi dei Rock Boys (la band di Adriano Celentano), per dare infine vita a I due corsari con Gaber, dal 1958 al 1960.

(Gaber e Jannacci)
E qui ci sono due cose da dire. Uno, che la Milano giovanile di allora, al netto dei tempi, mostrava già tutta la nevrosi della vita metropolitana che si stava formando: sono anni di botte, rivalità tra gang, comparsa dei Teddy Boys, che conducono una vita scioperata al bar, a giocare a flipper e a gettonare il juke-box, disturbano la quiete pubblica, scippano, rubano auto, compiono rigorosamente in gruppo azioni vandaliche per appropriarsi dei beni di consumo che stanno divenendo status symbol ma che la loro condizione sociale o anagrafica (giovani ricchi cui i genitori negano i soldi) gli impedisce di avere. Una rivolta confusa e anarchica, quasi luddista, che rifiuta insieme il buon senso dei genitori e l’etica del lavoro e della ricostruzione di un’Italia uscita distrutta dalla guerra. Sono l’annuncio del capitalismo consumista e insieme il rifiuto del suo meccanismo (che i CCCP, molti anni dopo, sintetizzeranno in Produci, consuma, crepa).
Ai Teddy Boys piace il rock’n’roll. E il rock’n’roll milanese nasce all’insegna del non-senso, che si esprime nei testi di Ghigo (“Tu mi piaci di più / se non ti vesti di blu”) e Clem Sacco (“Non ti accontenti più / del mio puro amor / sai che ti dico allor: / Baciami la vena varicosa / succhiami il dente del giudizio / strappami il pelo del neo”, con evidenti allusioni sessuali), poi edulcorate dai parolieri (Calabrese, Franchi, Migliacci, Beretta, Vivarelli) di Celentano, Mina, I due Corsari, ma sempre presenti. Ancora Manfredi: “Allora chi ballava il rock era detto "Balabiot bauscia", cioè "Danzatore nudo salivante", cioè epilettico. Mi hanno raccontato di Enzo che, ballando, lasciò la dama e si buttò a torcersi per terra”. È qui che si forma il gusto del surreale e l’attenzione al diverso che caratterizzeranno la sua produzione d’autore.
Due, questo rock’n’roll non è proprio tale, duro e puro, come magari ce lo immaginiamo oggi sulla scorta di quello che successe in Usa. No, il rock’n’roll per noi italiani, alla periferia dell’impero, era un genere non ben distinto dal country, dal melodico “urlato” (e non più cantato con voci educate e garbate, confidenziali, da crooner) e perfino dal jazz (del resto, se si ascolta Scotty Moore, leggendario chitarrista di Elvis, si capisce quanto, nel sound e nel playing, questi generi fossero intrecciati all’origine del rock).
Insomma il rock’n’roll per gli italiani non è che una forma del jazz, più dura e più dance, ma sempre jazz. Sempre Manfredi: “Enzo è un jazzista anche nei testi: dà il massimo quando si affida all’improvvisazione”. E proprio questa è l’altra chiave per capire Jannacci, che come inizia la sua produzione solista, a partire dal 1961, rivela di avere sulla punta delle dita molto jazz (altro che cantautore rock, altra fregnaccia ascoltata in questi giorni di commemorazioni). Sentite l’incrocio di tutti questi generi nel primo spot per Carosello di cui Jannacci scrive la musica, il mitico “Unca Dunca” che andrà in onda dal 1961 al 1970:

Quella in cui Nanni Ricordi pubblica i primi 45 giri di Enzo Jannacci da solista è ormai la Milano del boom, dell’immigrazione meridionale, anticipata qualche anno prima da Elio Pagliarani (1954-57) nel poemetto La ragazza Carla:
Carla Dondi fu Ambrogio di anni
diciassette primo impiego
stenodattilo all'ombra del Duomo
Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro
sia svelta, sorrida e impari le lingue
le lingue qui dentro le lingue oggigiorno
capisce dove si trova? TRANSOCEAN LIMITED
qui tutto il mondo...
è certo che sarà orgogliosa.
Signorina, noi siamo abbonati
alle Pulizie Generali, due volte
la settimana, ma il signor Praték è molto
esigente - amore al lavoro è amore all'ambiente - così
nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino
sarà sua prima cura la mattina.
UFFICIO A UFFICIO B UFFICIO C
È la Milano che da essere ancora un paesone diventa metropoli industriale e polo del terziario, in cui si perde la dimensione comunitaria e chi arranca non ha più un tessuto sociale e solidale intorno a sé, ma diventa un estraneo a tutto, un diverso, un disgraziato, in cui si smarrisce perfino la certezza comunicativa. Come si vede già nel primo 45 giri di Jannacci, dove nel lato A brilla la delicata Passaggio a livello, dove il nostro imita evidentemente Chet Baker in un clima cool jazz:

Il momento magico del possibile sbocciare di un amore interrotto per sempre dal passaggio di un treno, simbolo un po’ retrò e ingenuo dell’industrializzazione estirpatrice dei sentimenti (“Ma in un baleno / è schizzato via il treno / abbiam smesso di guardarci / poi mi hai chiesto se era un merci”). Qui c’è già il preludio del patetismo come dello schizo, espresso nella quasi rima (“quasi”, a distruggere l’armonia) “guardarci / merci”.
Il secondo 45 giri è già schizo, di quello schizo che è il canto disperato di chi è tragicamente escluso, per ragioni sociali, antropologiche o psichiatriche, dal mondo nuovo che si sta costruendo, e in cui si muove il protagonista anonimo del romanzo La vita agra (1962), venuto dalla Toscana in una Milano (in cui lavora, ma che non comprende e che non lo comprende) per far saltare con la dinamite la sede dell'industria chimica responsabile della morte di 43 operai, ma alla fine rinuncia: prima perché “sarebbe stato inutile e sciocco far esplodere io da solo […] la cittadella del sopruso, della piccozza e dell’alambicco. No, bisognava allearsi con la folla del mattino, starci dentro, comprenderla, amarla, e poi un giorno sotto, tutti insieme”; poi perché “non basta sganasciare la dirigenza politico-economico-social-divertentistica italiana. La rivoluzione deve cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi a rinunziare a quelli che ha”.
L’autore del romanzo è Luciano Bianciardi, che, dopo aver visto Jannacci esibirsi al Teatro Girolamo nello spettacolo Milanin Milanon proprio nel 1962, ne diventa amico, gli scrive le belle note di copertina del suo primo lp (La Milano di Enzo Jannacci, dicembre 1964, Jolly Records) e lo vuole nel film omonimo che il regista Carlo Lizzani trae da La vita agra con Ugo Tognazzi protagonista (nelle sale il 22 aprile 1964). La scena in cui compare Jannacci, nei panni a lui consueti di cantante in un locale milanese, è illuminante:

Qui c’è tutto: il PCI che ha rinunciato a ogni prospettiva rivoluzionaria (in perfetta linea con il “centrismo” stalinista anche in epoca post-staliniana), l’astrattezza teorica degli intellettuali antagonisti (compresi il personaggio di Tognazzi e Bianciardi, che compare muto in un cameo nel dialogo finale della scena), la concretezza degli operai per i quali i discorsi di Tognazzi sono surreali e incomprensibili: e ad essi rispondono perciò in maniera surreale e sarcastica. Ed ecco quindi il nuovo Jannacci, che non racconta, ma interpreta un personaggio.
Il protagonista vero di L’ombrello di suo fratello è solo in parte chi cerca il parapioggia: molto di più lo è lo spostato che non comprende quello che vede, lo racconta in modo surreale e con una vocalità che ne mima lo scompenso psichico. L’ispirazione musicale è popolareggiante a livello di armonia, ma l’esecuzione, gli stacchi, il ritmo, sono inequivocabilmente jazz. Ancora Manfredi: “Jannacci, raccontando questi personaggi in prima persona, ne illumina l’individualità, ci aiuta a vedere il personaggio non come una macchietta (tipo il Cerutti Gino di Simonetta/Gaber), ma come una persona autentica che ci racconta la propria vita”.
Dopo il cambio di vocalità, arriva quello di lingua. Ed ecco quindi lo Jannacci in dialetto milanese, parallelo alla collaborazione con Fo, Strehler, Carpi, Amodei e Fortini (i quali, ideologizzando, avevano creato perfino un’immaginaria malavita milanese mai esistita – Strehler e le sue canzoni della “mala” per la Vanoni, di cui Jannacci riprende Ma mi – e immettevano massicce dosi di coscienza proletaria negli esclusi, che per definizione marxiana proletari non sono, bensì semmai sottoproletari, quando la loro esclusione non sia dovuta a problemi psichici come detto prima), che riempie di sé, anche se non totalmente, gli lp La Milano di Enzo Jannacci ed Enzo Jannacci in teatro (1965), forse il primo album live italiano.

El portava i scarp del tennis, tutta jazz,è un capolavoro del filone schizo. Uno, perché chi racconta è un altro barbone, all’inizio e alla fine, che nell’intermezzo cede la voce (che infatti si fa ancora più stralunata) al protagonista, che neppure canta, ma parla dato che vive in totale disarmonia col mondo. Due, perché questa disarmonia è descritta nei suoi atti, nel suo parlare da solo, nel suo essere innamorato di una che nemmeno conosce, di un innamoramento così matto e immaginario da essere definito attraverso frasi in italiano, quindi di una retorica falsa ed astratta (“rincorreva già da tempo un bel sogno d’amore” e “che pareva il tricolore” sono espressioni da romanzetto simil-dannunziano).
Tre, perché il protagonista è un escluso che, nella sua miseria estrema, insegue i sogni del consumismo (porta le scarpe da tennis, implora di fare un giro in macchina e gioisce per questo come un bambino incredulo): una versione innocente ed innocua dei Teddy Boys di qualche anno prima. Quattro, perché muore nell’indifferenza generale (“L'han trovaa sòtta a on mucc de carton, / gh'han guardaa el pareva nissun / gh'han toccaa, el' pareva ch'el dormiva: / 'Lassà stà, che l'è ròba de barbon'”) di una città, anzi di una società, che si muove troppo in fretta per aver compassione di chi resta indietro (la stessa scena c’è nel film La vita agra e chissà a chi è venuta in mente prima, se a Bianciardi – nel romanzo, a memoria, non c’è -, a Lizzani o a Jannacci, dato che il 45 giri di "El portava i scarp" del tennis esce il 12 marzo 1964).
Cinque, per la sua reinvenzione del milanese, che non è quello “storico”, filologico, ma è istintivo, fonetico, eppure proprio per questo autenticamente popolare: qui Jannacci da un lato usa la parola “come grido, come verbalizzazione selvaggia, come lingua-jazz” (sempre Manfredi), dall’altro intuisce e anticipa quello che sarebbe divenuto il milanese dei giovani bene, degli intellettuali e degli immigrati di prima e seconda generazione. È, insomma, “il milanese dell’estraneo”, che diverrà popolare in tutta Italia attraverso Cochi e Renato o il primo Diego Abantantuono, tutti comici con cui Jannacci collaborerà.
Sarà questo filone più autentico dell’ispirazione di Jannacci a portarlo al successo, perché la gente ne coglierà istintivamente l’aderenza alla realtà. Quando nel 1968 Jannacci esplode con Vengo anch’io, no tu no (uscito a novembre 1967, comparirà in Top Ten solo il 6 aprile 1968, restandoci 11 settimane), scritto con Fo, lo fa proprio perché ne ha espunto dal testo le parti più politiche, guarda caso quelle scritte dall’attore milanese:
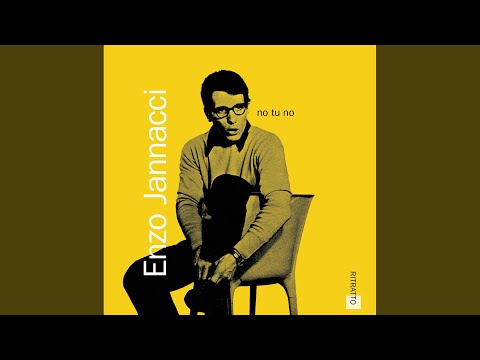
Due strofe sono scomparse. Eccole: “Si potrebbe andare tutti insieme nei mercenari / vengo anch’io? No tu no / giù nel Congo da Mobutu a farci arruolare / poi sparare contro i negri col mitragliatore / ogni testa danno un soldo per la civiltà / Vengo anch’io? No tu no // Si potrebbe andare tutti in Belgio nelle miniere / Vengo anch’io? No tu no / a provare che succede se scoppia il grisù / venir fuori bei cadaveri con gli ascensori / fatti su nella bandiera del tricolor”.
Toglierle è un modo non solo per sfuggire alla censura e poter presentare la canzone in tv e in radio, ma anche per rendere i protagonisti della canzone due personaggi collettivi, in cui ognuno di noi può riconoscersi: quello che preferiremmo essere, e quello che potremmo essere o almeno una volta nella vita siamo stati, “il rompicoglioni senza classe […], che vorrebbe inserirsi, comportarsi come gli altri, […] esserci tanto per esserci. Ed è escluso. Senza motivo. Solo per il fatto che ogni compagnia presuppone e impone un escluso. Ogni divertimento implica uno di cui si ride, ma che non deve ridere. Neppure nel mondo dell’odio reciproco […] c’è posto per lui. Neppure al suo funerale”.
Ma Jannacci finirà per odiare l’aspettativa creatasi intorno a lui, cioè di essere quello che presenta personaggi di cui si ride. Perché l’essenza di quei personaggi è tragica e, se di loro si ride, lo si dovrebbe fare solo per poi accorgersi della loro tragicità. Butterà quindi via il successo, presentandosi in finale a Canzonissima 1968 con la suddetta mielosa Gli zingari, uscendo alla seconda fase delle eliminatorie dopo aver trionfato nella prima. Finirà per autocensurarsi, ed è un vero peccato. Racconta infatti Manfredi, sempre della genesi di Rido: “La prima volta che sentii Enzo suonarlo mi esaltai perché più schizo di così, pensai, non si poteva. Enzo cantava: "Rido, mi piscio sotto e rido, mi brucia il culo e rido… quando mi tira rido". Il testo illuminava anche il lapidario O vivere o ridere messo in copertina. Purtroppo scomparve la piscia, scomparve il «quando mi tira», scomparve praticamente tutto, tranne le bellissime risate tese e il 'gatto sulle strisce'. Il tutto rimase astratto, troppo astratto e la risata perse di corrosività”.
---
L'articolo Enzo Jannacci, quello vero: lo "schizo" della musica italiana di Renzo Stefanel è apparso su Rockit.it il 2013-04-02 12:49:00


COMMENTI