Grandi canzoni di pop italiano come soltanto pochi saprebbero mettere, tutte insieme, in un unico full lenght.
Torna sul luogo del delitto Fabio Campetti (assumendo con ciò, che le sue canzoni siano pericolosissimi sicari che mirano dritto al cuore non lasciando scampo alcuno) e lo fa con una delle suoi molteplici creature, questa volta a nome Intercity. Autore prolifico e padre putativo di altri due progetti (Edwood e Campetty), l’autore bresciano, accompagnato stabilmente dal fratello Michele, mette in scena il terzo episodio della sua personalissima saga infarcita di storie d’amore sghembe, spaccati di quotidianità e citazionismo mai fine a se stesso. Dopo l’esordio di “Grand Piano” datato 2009 e il seguito “Yu Hu” del 2012 – dove, in larga parte, possiamo cogliere innumerevoli trait d’union con il lavoro in oggetto – Campetti e soci (sono della partita anche Dario Fugagnoli – batteria, Giulia Mabellini – violino, Paolo Comini – basso) ci sciorinano dodici episodi dal peso specifico del platino, dodici potenziali singoli che ci sbattono in faccia una grandeur pop come raramente ci è dato ascoltare nel belpaese.
Prendete i Baustelle meno catatonici, degli Amor Fou posseduti da una sorta di joie de vivre inconsapevole, il Paolo Benvegnù più “scismatico” ed ecco che, alla lontana, ma molto alla lontana, avrete un’idea di che cosa vi aspetta premendo play sul lettore. “Un Cielo Cinghiale” narra di un amore al capolinea, silenzi e vuoti che si fa prima a lasciarsi alle spalle che a riempire con dolore (“Come siamo lontani anche se vicini/a volte silenziosi a volte premurosi/qui convive il silenzio e non si parla più”): poco più di due minuti dove cantautorato e irruenza punk convivono con stile. I mid tempo di “Tu” e “Reggae Song” dettano le coordinate che seguirà il resto dell’album: grandi canzoni di pop italiano come soltanto pochi saprebbero mettere, tutte insieme, in un unico full lenght. Le melodie killer di “Indiani Apache” e “Kyoto” (singolone italiano dell’anno, per quanto mi riguarda), tra rarefazioni, aperture e archi mesmerizzanti, ci traghettano verso metà percorso. “Amur” è uno di quei pezzi che Francesco Bianconi ha disimparato a scrivere ormai da troppo tempo, “A” prende a braccetto Altro e Virginiana Miller per condurli in una strano interludio a metà tra canzone d’autore e iconoclastia; e mentre “Polar” e “Le Avanguardie” chiudono i giochi, l’impressione di avere per le mani un disco importante, è definita e netta.
Chi si chiedeva perchè una band di tale spessore non fosse ancora annoverata tra i soloni della musica che conta, oggi avrà ulteriori motivi per rodersi il fegato. Perché Campetti e soci, nonostante abbiano sfornato un altro piccolo capolavoro, probabilmente non si assicureranno il premio Tenco o un passaggio in radio (ovviamente speriamo di sì per loro), ma più prosaicamente continueranno ad allietare le serate di noi poveri sfigati meteoropatici con il vezzo della musica che smuove e commuove.
---
La recensione AMUR. di Scritto da Giulio Pons è apparsa su Rockit.it il 2015-09-02 09:00:00

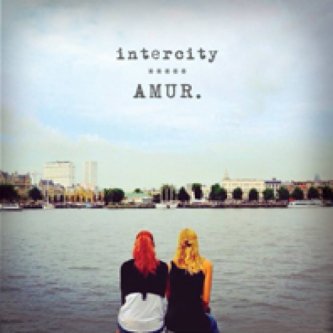


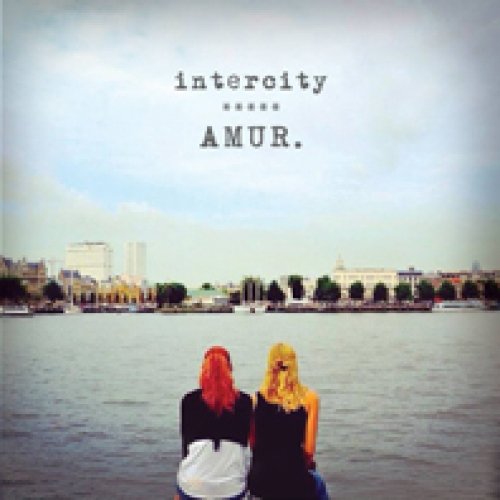
COMMENTI